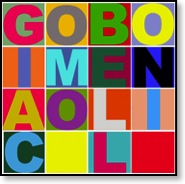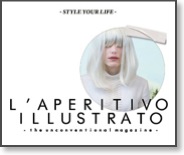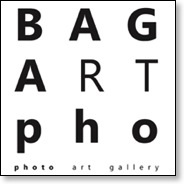Testo pubblicato su:  _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
L'Aboutness e l'Embody
di Giacomo Belloni
What Warhol taught was that there is no way of telling the difference (between art and non-art) merely by looking. The eye, so prized an aesthetic organ when it was felt that the difference between art and non-art was visible, was philosophically of no use whatever when the differences proved instead to be invisible. Arthur C. Danto
Danto è professore di filosofia alla Columbia University. Ha pubblicato molti libri, è autore di saggi e di scritti critici e lavora per molte riviste e giornali.
Le Brillo Box di Andy Warhol, opera su cui ruota il suo saggio, esposte nel 1964, sono state accolte dalla critica freddamente e con grande scetticismo. Al contrario, per Danto, queste sono state il pretesto per analizzare una vera e propria rivoluzione nel mondo dell'arte e della filosofia. Le scatole Brillo sono il punto focale per la comprensione di alcuni complessi meccanismi filosofici che riguardano l'arte nella sua modernità.
Nel suo saggio egli arriva a dimostrare che l'occhio non è più in grado di vedere, come in precedenza, e la conoscenza dell'opera contemporanea avviene attraverso altri e differenti meccanismi: se le sculture di Warhol sono visivamente uguali alle Brillo reali - quelle del supermercato - per quale ragione le prime sono da considerare opere d'arte mentre le seconde no? La funzione ed il valore dei due oggetti sono differenti anche se appaiono assolutamente identici.
Inoltre, con la perdita di importanza dei meccanismi della visione Danto sostiene che la differenza tra “the art” e “that-which-is-not-art” non ha nulla a che vedere con l'idea di bellezza - nella sua accezione secentesca - per cui suggerisce di partire da tutt'altro presupposto: dalle intenzioni che sono antecedenti all'opera o all'oggetto. Per molto tempo l'estetica ha considerato determinante il concetto di bellezza escludendo dal mondo dell'arte ogni manufatto non esteticamente rilevante. Nel corso del ventesimo secolo invece questa presupposta qualità ha perso completamente valore; alcuni movimenti artistici hanno addirittura fatto del brutto la loro forza espressiva, trasponendo l'importanza dell'opera, non più sulla sua qualità estetica, ma nel suo significato incarnato, nei suoi valori concettuali. Questa relativizzazione della bellezza ha di conseguenza consentito un'evoluzione ed un cambiamento anche per le teoria della filosofia e dell'estetica stessa: un'opera va analizzata sotto un'altra angolatura; bisogna ricercare nei significati le condizioni essenziali che ne legittimano l'esistenza.
Danto divide la storia dell'arte in tre fasi: la prima, quella dell'arte mimetica, è rimasta in auge fino al XIX secolo. In questo lungo periodo l'arte si è evoluta con una progressione lineare tanto da poterla quasi considerare sotto un unico comune denominatore.
La seconda fase inizia con il Modernismo, a partire dall'ultimo ventennio del XIX secolo hanno coesistito molti generi; dal 1910 al 1930 hanno convissuto correnti e movimenti che spaziavano dal genere tradizionale all'astrazione, dal minimalismo al futurismo, dal dada al cubismo.
La terza fase, secondo Danto, nasce con la Pop Art, ed è stata caratterizzata dal fatto che qualsiasi cosa o nulla (anything and everything) sarebbe potuta essere stata considerata arte, senza alcun limite. È questo il momento in cui la vista abbandona il suo ruolo dominante a favore della critica dell'arte e della filosofia.
Nel corso della storia è stato dato sempre per scontato che le opere d'arte avessero un'identità precostituita, che a priori fossero qualcosa di unico confinato in un ambito definito ed esclusivo. Solamente in tempi recenti, quando queste hanno iniziato a confondersi e a commistionarsi con il mondo degli oggetti, si è sentita la necessità di fare chiarezza per capire fino a che punto le une potessero confondersi con gli altri. In prima analisi potrebbe apparire che gli oggetti non ascrivibili all'alveo dell'arte sono quelli con una funzione esclusivamente utilitaristica, che servono a qualcosa; ma come vedremo tra poco non è così chiaro e semplice ed il confine tra le due dimensioni è molto labile.
Danto si chiede quali siano le caratteristiche che fanno sì che un'opera non appartenga al mondo degli oggetti ma a quello dell'arte. Prende come esempio ciò che aveva già trattato nel volume "The trasfiguration of the commonplace" ove sosteneva che il confine, tra opera ed oggetto non è poi così scontato, basti vedere i ready made di Duchamp i quali, secondo quanto detto finora, non sarebbero opere d'arte. Basti vedere Bottle rack, o Fountain, o ancora la Rue de bicyclette, tutti oggetti con funzioni precise, spesso veri e proprio utensili che invece, attraverso un mutamento di paradigma, cambiano classe di appartenenza e dal mondo comune passano a quelle dell'arte.
Per Danto le opere d'arte sono tali se, prima di qualsiasi altra cosa sono a proposito di qualcosa, un about che conferisce loro un contenuto; come seconda condizione le opere devono quindi incarnare un significato (emboby). Significato (aboutness) e contenuto (embody) sono quindi condizioni imprescindibili per dipanare la questione.
Cita a questo punto le tesi di George Dickie, secondo cui i quadri non oggettivi non sottostanno alla prima delle due condizioni: quella dell'aboutness. Non oggettivi sarebbero i lavori di Kandinskij, di Mondrian, di Malevic, ecc. gli autori le cui opere sono esposte al Moma, museo che in origine era proprio il museum of non objective arts. Tale denominazione, non objective, era stata utilizzata per la prima volta da Rodcenko e da Kandinskij per indicare un'arte pura che lascia fuori il mondo con l'intenzione di esprimere profondità private ed interiorità soggettive. Secondo Danto Malevic si sarebbe molto sorpreso qualora qualcuno gli avesse fatto notare che il suo Quadrato nero non poteva essere considerato a proposito di qualcosa.
Per dar manforte alla sua seconda tesi, quella dell'embody, Danto riprende le Brillo Box e chiarisce che, anche le scatole che sono in vendita nei supermercati sono about qualcosa - la spugnetta - e, nello stesso tempo, incarnano il loro significato, basta vedere i disegni e le scritte sulla scatola. Quindi, secondo le precedenti distinzioni, l'opera di Warhol e la scatola di detersivo non hanno particolari differenze. Le scatole dei supermercati potrebbero essere ready made.
Per complicare la questione Danto aggiunge ora un'altra scatola, apparentemente uguale alle altre, la Not Warhol Brillo Box, dell'artista americano Mike Bidlo. Questa era parte di un'istallazione che comprendeva 85 pezzi esposti in una mostra allestita a Zurigo dal titolo, appunto, Not Warhol Brillo Box.
Ora i livelli di analisi sono diventati tre: la Brillo del supermercato, la Brillo di Warhol e la Not Brillo. La prima viene inclusa da Danto nella categoria dell'arte pubblicitaria:; Harvey, l'artista che la ha creata nei primi anni 60, nel momento in cui l'Espressionismo Astratto stava oramai tramontando, ha voluto creare un prodotto seducente: ha utilizzato i colori della bandiera americana per richiamare il patriottismo, la stessa parola Brillo è d'effetto per quella sua modernità che si adatta perfettamente all'atmosfera positiva del momento, così come anche i motivi del design sulla scatola, sinuosi ed accattivanti come volevano le stesse regole estetiche che rendevano la Pepsi un prodotto giovane e di cui andar americanamente fieri.
Warhol da parte sua, con Brillo, ha voluto creare un'opera bella, che rispettasse i criteri estetici in voga nel 1964. Egli ne ha catturato volutamente solo l'aspetto esteriore eliminando tutte le ragioni che hanno portato Harvey a disegnarla in quel modo, quelle commerciali. Per Warhol le scatole sono state inoltre un modo per emanciparsi dall'Espressionismo Astratto.
Bidlo invece ripropone opere famose riprodotte con una motivazione logica a priori, le sue box sono quindi a proposito di qualcosa, ma in questo caso, a proposito delle sole Brillo di Warhol (e non di Harvey).
Nella realtà tutte e tre le scatole sono uguali alla vista, per questo Danto ci tiene a ribadire che spesso in arte i significati non appaiono all'occhio, organo privilegiato per le ragioni estetiche ma filosoficamente inutile. Chiosa dicendo che l'arte è quindi una questione filosofica che può e deve essere esplicitata dalla critica.
io@giacomobelloni.com
_________________________________________________________________
per approfondimenti si consiglia la lettura del libro:

![]()
_______________________________________________________________________________________
NOTA BENE: ARCHIVIOARTE non ha alcun fine di lucro. Ogni proposta qui contenuta ha la sola finalità di promuovere la diffusione dell'arte in quanto considerata patrimonio di tutti e per tutti. Ogni iniziativa, ogni azione ed ogni pubblicazione è autoprodotta e diffusa unicamente per amor di cultura e per il convincimento che la sua condivisione ci possa rendere più ricchi spiritualmente e più liberi.
Nulla di quanto qui pubblicato ha contenuti politici.
_______________________________________________________________________________________
"È vero, principe, che una volta avete detto che il mondo sarà salvato dalla bellezza?" Dostoevski, L'Idiota
_______________________________________________________________________________________