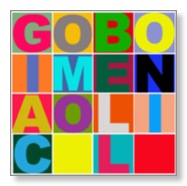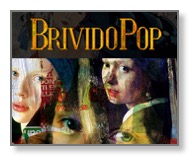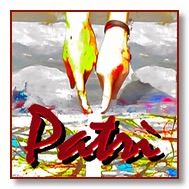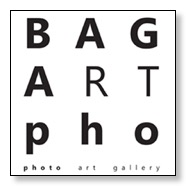Testo pubblicato su: 
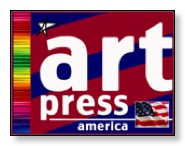
_________________________________________________________________
Rosalind Krauss ed il concetto di originalità dell'avanguardia.
di Giacomo Belloni
Nel 1981, alla National Gallery di Washington, si è svolta la più grande mostra mai organizzata sull'opera di Rodin. È stata esposta una quantità mai vista di sculture, tra le quali molte inedite: 366 lavori catalogati, provenienti da più di 40 collezioni, pubbliche e private, europee e americane.
Motivo di disamina della Krauss nel suo saggio è il concetto di originalità dell'opera d'arte. Già ben trattata da Walter Benjamin nel 1939 sul suo "L'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica" il concetto di originalità assume già da Rodin – e come vedremo anche da Monet - un valore completamente nuovo e differente.
Rodin aveva lasciato in eredità tutti i suoi gessi allo Stato francese, insieme al diritto di utilizzarli per realizzarne sculture in bronzo. Ora, a distanza di oltre sessant'anni venivano forgiate opere "originali" dagli stessi modelli, prodotte con i medesimi procedimenti utilizzati dall'autore.
Scrive la Krauss: at the time of Rodin death “The Gates of Hell” stood in his studio like a mamrnoth plaster cessboardwith all the pieces removed and scattered on the floor; una confusione di pezzi sparsi, pronti per la fusione ma lasciati in disordine casuale; il progetto per l’edificio a cui era destinata la porta era stato abbandonato ed il committente, lo Stato francese, non reclamava la consegna della porta.
Il primo tentativo di assemblaggio venne eseguito quattro anni dopo la morte di Rodin. Si può quindi dire che ogni fusione è una copia that exist in the absence of the original.
La Krauss cita ciò che Walter Benjamin aveva scritto nel suo saggio “Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”, nello specifico che il concetto di autenticità perde completamente valore se il medium dell’opera vive solamente di multipli. L’esempio più calzante sono le opere fotografiche dove, da un solo negativo possono essere stampate un numero indefinito di copie; nel caso della fotografia quindi il concetto di originalità perde completamente di senso. Come per Rodin, le fotografie di Aget hanno visto la luce unicamente dopo la scomparse del fotografo. O ancora, Cartier Bresson non stampò mai i propri lavori ma lo face fare da altri, esattamente come Rodin faceva fare per i suoi bronzi alle fonderie.
Questi concetti non includono solo la parte della produzione legata all’esecuzione materiale; per Rodin la copia è insita già nella nozione stessa di creazione artistica: ogni sezione, ogni figura esiste per essere unicamente un multiplo.
Come ha scritto nel libro “Passages in Modern Sculptures” del 1981, la Krauss spiega di come lo scultore francese abbia utilizzato gli stessi modelli per superare il concetto di narrazione, impiegati più volte nella loro essenza di multipli per più sezioni della Porta dell’inferno; è il caso del figliol prodigo o delle tre ombre. Queste ultime riproducono in multiplo per tre volte lo stesso corpo, parodiando, di fatto, il neoclassico ed il suo voler rappresentare una stessa figura con più angolazioni per dare il maggior numero di informazioni in uno stesso sguardo:
“Rodin made choice after choice and eliminated everything that was too solitary to subject itself to the great totality” (la visione d’insieme).
Ma, si chiede ancora la Krauss, possibile che Rodin, l’artista che ha più di tutti gli altri ha voluto celebrare la propria originalità, possa aver scelto di lasciare i propri originali all’incertezza di un futuro di multipli? O forse è il caso di uscire da un concetto da lui già superato, in cui l’originale che non ha più senso con i mezzi di riproduzione disponibili?
Nell’immaginario si concepisce originale qualcosa che è vicino al momento del suo concepimento; tanto più si è close to the aestetic moment, tanto più si valida qualcosa come fedele al proprio periodo. Ciò che stona con le fusioni postume di Rodin è proprio la distanza che le separa dal loro concepimento. Tale separazione temporale produce una stortura stilistica per cui, quello che è stato artisticamente pensato al tempo non potrebbe mai esserlo oggi, proprio perché le condizioni di oggi sono talmente differenti da produrre una sostanziale ed immediatamente percepibile diversità di stile. Quindi, come in fotografia dove si definisce la stampa originale “quella più vicina al momento estetico”, anche per le altre produzioni tale differenza riguarda lo stile. Scrive ancora la Krauss:
“A period style is a special form of coherence that cannot be fraudulently breached […] Thus an individual could not, by definition, consciously will a style. Later copies will be exposed precisely because they are not of the period.”
Ed è esattamente questo che non ci torna con la Port de l'Enfer e le sue fusioni postume.
Sicuramente, ciò che ha contraddistinto ed accomunato gli artisti delle avanguardie del secolo scorso, è proprio il tema dell'originalità, intesa questa volta come la ricerca di qualcosa di primordiale, originario, incontaminato dalle convinzioni culturali. Insomma, come disse Brancusi: “When we are not longer children, we are already dead”, o ancora Malevič: “Only he is alive who rejects his convinctions of yesterday”, il concetto stesso d'avanguardia nel 900 sembra essere strettamente connesso con l'originalità. A questa vanno aggiunte le nozioni di repetition e recurrency e la figura della griglia, the grid. Quest'ultima ha molteplici qualità: la prima è la sua impermeabilità al linguaggio (imperviousness to language), quindi l'assenza di gerarchia, di centro, di inflessioni che ne sottolineano il carattere autoreferenziale, non consentendo la proiezione del linguaggio nel dominio del visivo con il risultato di riuscire a creare il silenzio (lack of hierarchy, of centre, of inflection, emphasizes its referential characters […] will not permit the projection of language into the domain of the visual, and result is silence). La griglia infatti pone una barricata nei confronti di qualsiasi discorso ed è impermeabile verso ogni intrusione. La griglia è inoltre emblema del disinteresse puro dell’opera, condizione da cui deriva la sua promessa d'autonomia. La griglia facilitava questo senso dell’essere nata in un nuovo spazio ripulito, di purezza estetica e di libertà, lo spazio di un nuovo inizio, un ground zero.
Paradosso della griglia è quella di essere una prigione nella quale l'artista ingabbiato si sente libero, proprio perché estremamente restrittiva e limitante. Se si analizzano artisti come Mondrian, Albers, Reinhard e Agnes Martin diviene chiaro che una volta arrivati alla griglia, questi non sono più riusciti ad uscire dalla ripetizione, cessando di evolversi differentemente.
Altra particolarità della griglia è che nessuno può rivendicarne il fatto di esserne l'inventore: questa può solamente essere ripetuta.
Ma, scrive ancora la Krauss, c'è un'altra ancor più convincente finzione: l'illusione non dell'originalità dell'artista, ma quella – intesa come originaria – della superficie pittorica, della superficie della tela, the canvas surface. La griglia la segue, la ripete e la doppia: una figura originaria riportata sul supporto, già di per sé origine.
What I have been calling the fiction of the originary status of the picture surface is what art criticism proudly names the opacity of the modernist picture plane. Opacità è una finzione dello status originario. Per il modernismo il piacere è lo spazio dell'autoreferenzialità che inizia dalla possibilità semiotica di un segno pittorico non rappresentativo e non trasparente. La griglia modernista replica la superficie pittorica isolando il significante di un sistema di griglie precedente ed ancora, ed ancora. La griglia modernista è esattamente come le fusioni di Rodin, un multiplo, qualcosa che moltiplica, che doppia, in un sistema di riproduzioni senza originale.
Nei primi anni del diciannovesimo secolo era già scontato che una copia fosse una naturale declinazione di un originale. La Krauss porta l'esempio di Jane Austen: in Northanger Abbey, lascia Catherine scoprire come in tema di pittoresco la natura è essa stessa concepita come possibilità di essere trasformata in opere d’arte, di essere moltiplicata, raddoppiata. Ogni paesaggio diviene una copia di un quadro da cui è stato preceduto. Mentre nell’ambito del pittoresco la differenza tra originale e copia era molto meno evidente, essendo ogni opera una ripetizione di un concetto declinato su una continua doppiatura, già alla fine del secolo tale l'interdipendenza tra originale e copia si affievolisce per rafforzare la nozione del primo a svantaggio del secondo.
L'apertura di un museo delle copie nel 1834, sotto la direzione di Charles Blanc, ha consentito che il segno spontaneo trovasse e radicasse una sua identità; questo era rappresentato dai tocchi interrotti, dalle spatolate (che Monet più tardi chiamò istantaneità, o Pochade, termine utilizzato per definire uno schizzo rapido, un abbozzo, un appunto artistico, un abbozzo). In realtà Monet non era così istintivo come a prima vista poteva apparire, al contrario, ogni suo intervento era fortemente meditato. I suoi lavori venivano prodotti insieme, quasi in serie , come abbiamo visto per Rodin.
Ecco quindi che ancora ritroviamo, in Monet come in Rodin, la stessa economia estetica espressa con i termini singolarità e molteplicità, unicità e riproduzione. Ancora: ciò porterà alla frattura dell'origine empirica che sarà il precedente storico per la griglia modernista. Il discorso sull'originalità reprime e scredita il concetto di copia e, sia l'avanguardia che il modernismo si basano su questa rimozione.
The production of spontaneity through the constant overpainting of canvases employs the same aesthetic economy of the pairing of singularity and multiplicity, of uniqueness and reproduction, that we saw at the outset in Rodin’s method. In addition, it involves that fracturing of the empirical origin that operates through the example of the modernist grid. But as was true in those other cases as well, the discourse of originality in which impressionism participates represses and discredits the complementary discourse of the copy. Both the avant-garde and modernism depend on this repression.
Giacomo Belloni
_________________________________________________________________
per approfondimenti si consiglia la lettura del libro:
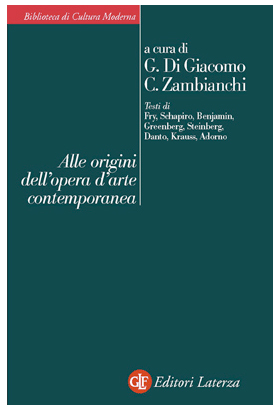
_______________________________________________________________________________________
NOTA BENE: ARCHIVIOARTE non ha alcun fine di lucro. Ogni proposta qui contenuta ha la sola finalità di promuovere la diffusione dell'arte in quanto considerata patrimonio di tutti e per tutti. Ogni iniziativa, ogni azione ed ogni pubblicazione è autoprodotta e diffusa unicamente per amor di cultura e per il convincimento che la sua condivisione ci possa rendere più ricchi spiritualmente e più liberi.
Nulla di quanto qui pubblicato ha contenuti politici.
_______________________________________________________________________________________
"È vero, principe, che una volta avete detto che il mondo sarà salvato dalla bellezza?" Dostoevski, L'Idiota
_______________________________________________________________________________________